di Giuio Mozzi
L’incontro con il quadro di Claudio Laudani Discorso attorno a un sentimento nascente (di cui ho raccontato qui) non fu privo di conseguenze. Da qualche tempo andavo scrivendo nel mio diario in rete (oggi perduto) delle storielle nelle quali appariva una (prima) trasfigurazione di Claudio, che chiamavo Grande artista sconosciuto (perché Claudio è secondo me un grande artista, ed è effettivamente sconosciuto). Erano delle storielle buffe – credo, spero -, comunque certamente non serie. Ma dopo aver visto quel quadro provai a scrivere qualcosa di veramente serio su Claudio (la seconda trasfigurazione). Uscirono così dei capitoli (in prima persona) che integrai a quanto era rimasto dell’Introduzione ai comportamenti vili, e intitolai il tutto Discorso attorno a un sentimento nascente. L’idea era di continuare a presentare il protagonista – che ora, come già ho detto, portava il mio nome – come un personaggio un po’ abulico, ma la cui vita veniva sfiorata da una quantità di vite straordinarie (nel bene e nel male). Ne avevo in mente, di vite straordinarie. Il primo episodio di “sfioramento” concerneva il Terrorista Internazionale. Il cui corpo – questo era il nocciolo dell’episodio – non recava nessuna traccia di ciò che egli era stato.
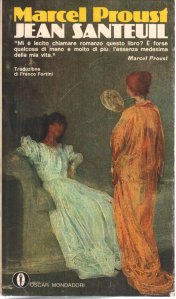 Questo fu il primo spostamento. Dalle “vite straordinarie” alle “vite che non lasciano traccia sui corpi di chi le porta”. Il tema mi affascinò per un po’. Nelle prime pagine del Jean Santeuil (così è intitolato, credo dai filologi, il primo tentativo di Marcel Proust di scrivere il suo romanzo) il protagonista, appunto Jean, incontra uno scrittore famoso, da lui molto ammirato: e si stupisce di trovarlo anonimo, quasi dozzinale, completamente diverso dall’artista che aveva immaginato a partire dai libri (cito a memoria e spero di non sbagliare). Così noi spesso ci stupiamo nell’incontrare persone che, per così dire, non assomigliano alla loro vita (o almeno: non lasciano trasparire quella che noi immaginiamo essere la loro vita vera). Ma la vita, in effetti, che tracce lascia sul nostro corpo? In tutti noi, credo, giace un’idea un tantino ottocentesca, in un certo senso lombrosiana (un lombrosismo rovesciato), per cui se una persona ha attraversato certe esperienze particolari, o addirittura eccezionali, o è stata capace di creare grandi opere, o di commettere grandi delitti, eccetera, di tutto ciò nel suo corpo una traccia *deve* esserci.
Questo fu il primo spostamento. Dalle “vite straordinarie” alle “vite che non lasciano traccia sui corpi di chi le porta”. Il tema mi affascinò per un po’. Nelle prime pagine del Jean Santeuil (così è intitolato, credo dai filologi, il primo tentativo di Marcel Proust di scrivere il suo romanzo) il protagonista, appunto Jean, incontra uno scrittore famoso, da lui molto ammirato: e si stupisce di trovarlo anonimo, quasi dozzinale, completamente diverso dall’artista che aveva immaginato a partire dai libri (cito a memoria e spero di non sbagliare). Così noi spesso ci stupiamo nell’incontrare persone che, per così dire, non assomigliano alla loro vita (o almeno: non lasciano trasparire quella che noi immaginiamo essere la loro vita vera). Ma la vita, in effetti, che tracce lascia sul nostro corpo? In tutti noi, credo, giace un’idea un tantino ottocentesca, in un certo senso lombrosiana (un lombrosismo rovesciato), per cui se una persona ha attraversato certe esperienze particolari, o addirittura eccezionali, o è stata capace di creare grandi opere, o di commettere grandi delitti, eccetera, di tutto ciò nel suo corpo una traccia *deve* esserci.
Nei corpi del Terrorista Internazionale, del Capufficio, del Giornalista Comunista (li chiamavo così, i personaggi; e così hanno continuato a chiamarsi anche nella redazione finale del romanzo) sembrava non essere rimasta nessuna traccia della loro vita – terribile o eroica che fosse stata. E questo, va bene, può essere un tema interessante. Ma – l’azione? Che tipo di azione potevo pensare di infilare in questo cumulo di storie disparate? E come potevo condurre poi l’azione a quel “nascere del sentimento” annunciato, promesso dal titolo (e dal quadro, che piazzai ovviamente nella prima pagina)?
Non c’era verso. Non ne uscivo. Più o meno nel 2002 decisi, sostanzialmente, di lasciar perdere. Agli amici che mi chiedevano del “famoso romanzo” rispondevo, per tagliare corto: “L’ho finito, ma non mi piace”. Delle due affermazioni, solo la prima era una bugia.
Fu nel 2005, credo – vado veramente a memoria, e la mia memoria è inaffidabile – che tentai di rimettere in moto il tutto. Per prima cosa scrissi un nuovo primo capitolo, completamente (mi pareva) diverso dagli altri. Che aveva un attacco davvero (mi pareva) vincente.
* * *
“Scrivo questo romanzo perché ho bisogno di soldi”. Questa, all’incirca nel 2005, era la prima frase del primo capitolo (nuovo) dello scartafaccio in corso d’opera. Le facevano seguito una ventina di cartelle che oggi mi sembrano non tanto inutili quanto depistanti. Ma non depistavano il lettore: depistavano me. Fornivano all’esistenza del romanzo una ragione che – in teoria – avrebbe dovuto servirmi a “prendere le distanze”, come si usa dire, dalla materia; e in effetti riuscirono nell’intento: da quel dì lo scartafaccio rimase immobile. Ci tornai sopra diverse volte, certo, ma sempre senza convinzione, e senza fare altro che spostare qualche virgola. Se lì dentro c’era la possibilità di un romanzo, l’avevo senz’altro ammazzata.
Ma.
Ma nel frattempo succedevano delle cose. Nel frattempo successe, per esempio, sempre più o meno nel 2005, che un giorno mi sedetti e scrissi una porzione – diciamo una decina di cartelle, almeno, di una lettera: la lettera di una figlia al padre. Argomento della lettera: (omissis). (O vi piacciono gli spoiler?). Una lettera drammatica e paradossale, forse scandalosa. Che nulla aveva che fare con le storie latenti nel romanzo. Eppure… Eppure ebbi, non da subito, ma diciamo qualche anno dopo, la sensazione che comunque quella lettera stava “nel clima” del romanzo. La donna scrive, scrive: ha ricevuto dal padre una lettera, una busta bella grossa, e gli risponde, però non ha nessuna intenzione di aprire la lettera del padre, di vedere che cosa c’è dentro. Quella decina di cartelle poteva essere, così a occhio, una metà della lettera. La finirò domani, nei prossimi giorni, mi dissi. Restò lì per anni. Restò lì, però, anche nel senso che non se ne andò.
Sicuramente nel 2005, poi, la rivista Nuovi argomenti mi chiese un pezzo per un numero la cui parte tematica s’intitolava: “Personaggi sommersi”. Scrissi un pezzo lungo, sicuramente troppo lungo, nel quale dapprincipio parlavo di Giovanni Paolo II, che se n’era andato da poco, poi parlavo d’altro, poi a un certo punto scrivevo:
Non ho assistito a quasi nessuno dei grandi eventi che sono avvenuti durante la mia vita. Grazie alla televisione, quasi tutti i miei amici – che sono più o meno miei coetanei – hanno assistito a tutti i grandi eventi che sono avvenuti durante la loro, e la mia, vita. Si può discutere se guardare in televisione il papa che spalanca la bocca senza riuscire a fare nessun suono, se guardare in televisione due aeroplani che si infilano nelle Twin Towers, se guardare in televisione Paolo Rossi che si tuffa tra i piedi dei brasiliani e fa gol di testa colpendo una palla che rimbalza a una spanna dal terreno – se questo possa essere veramente detto: assistere. Però so che la liberazione del generale James Dozier, della quale non ho vista nessuna immagine in movimento ma alla quale ho assistito ascoltando la cronaca incasinatissima che il militante faceva dalla cabina del telefono, è un avvenimento al quale mi sembra di avere, appunto, assistito. Se questsa mia assistenza sia vera o no, vera nel senso che veramente ho assistito alla liberazione del generale Dozier tra le undici e mezza di mattina e il mezzogiorno del 28 gennaio 1982, così come circa alle otto di sera del 23 luglio del 1981, all’ospedale di Grosseto, ho assistito alla morte di Lucia investita alle quattro di mattina, mentre camminava lungo la strada in cerca di non si sa cosa, da un automobilista ubriaco: questo non lo so. So che ciò che mi pare, è di avere assistito. Ho prestata assistenza alla realtà, perché potesse avvenire. Se io non fossi stato lì, la morte di Lucia sarebbe rimasta incompleta. Se io non fossi stato in ascolto di Radio Sherwood, la liberazione del generale James Dozier sarebbe rimasta un avvenimento incompleto. Il mondo ha bisogno della mia assistenza, penso, per avvenire.
Qui dentro, confusamente, c’è qualcosa. E da questo punto qui dell’articolo, tutto cambia: e comincio a parlare del generale Luigi Cadorna. Il pezzo intero si può leggere in Nuovi Argomenti, quinta serie, n. 30, aprile-giugno 2005. Ma che cosa è che c’è, qui dentro, sia pure confusamente? Qualche anno dopo, ma non saprei dire esattamente quando, la seconda parte di quel pezzo (quella del generale Cadorna; la prima parte, compreso il pezzo che ho citato qui, sparì) entrò a far parte dello scartafaccio. Era pur sempre anche quella una storia di “vita sfiorata” (non da Mario direttamente, ma dal nonno materno di Mario).
Poi per qualche anno in sostanza non accadde più nulla. Però nel 2010 pubblicai per le edizioni :duepunti un piccolo piccolo libro, La stanza degli animali (http://www.gianfrancofranchi.com/la-stanza-degli-animali/; ora quel testo è incluso nel volume Favole del morire, Laurana). E quel piccolo libro io lo considero l’inizio di un ritorno, dopo tanto allontanamento. (Per qualche tempo, tra il 2009 e il 2015, provai a inserire La stanza degli animali, così com’era, dentro lo scartafaccio del romanzo: feci un copia/incolla, e null’altro). Un ritorno lento, lento, lento.
A questo punto, lo stato dell’opera era:
– uno scartafaccio sostanzialmente del 1998, intitolato Introduzione ai comportamenti vili, in terza persona;
– uno scartafaccio prevalentemente del 2002, con interventi del 2005 circa, intitolato Discorso attorno a un sentimento nascente, in prima persona, in parte composto da episodi provenienti dal primo scartafaccio;
– una mezza lettera d’una figlia al padre, scritta nel 2005, separata ma che percepivo come legata ai primi due scartafacci;
– alcuni testi sparsi (il testo per Beatrice Pasquali; il pezzo su Luigi Cadorna; forse dell’altro, credo poco altro), scritti tra il 2000 e il 2010, che pian pianino scivolavano verso gli scartafacci;
– La stanza degli animali, sicuramente un testo nato nell’ambito delle immaginazioni del romanzo, ma del tutto finito, e quindi inevitabilmente separato – nonostante i miei tentativi di incollaggio.
* * *

“Cosa altro possiamo aspettarci da Mozzi scrittore, dopo tutto quello che ha già detto e fatto? Hai qualche progetto in cantiere? Romanzi o racconti o testi tuoi, intendo?”
“C’è un romanzo che è lì da un pezzo – da una quindicina d’anni, intendo –, si chiama Discorso attorno un sentimento nascente, ogni tanto ci rimetto le mani: il problema è che non mi piace, e non ho chiaro che cos’è che non va. Alla mia età, non ha senso metter fuori un lavoro che non mi convince. Del resto, io sono ormai – e felicemente, sia chiaro – un ex scrittore. […] La mia migliore qualità, come scrittore, è l’aver smesso”.
Così dichiaravo nel marzo del 2018 a Gianluca Barbera, in un’intervista pubblicata da Pangea.
“Gli scrittori non cessano mai di esserlo, si dice. Lei invece dice di aver smesso di esserlo”.
“Non ho smesso, ma ho finito”.
Così qualche mese prima a Niccolò Menniti Ippolito, in un’intervista pubblicata nel quotidiano della mia città, Il mattino di Padova.
Non stavo mentendo. Dicevo quella che all’epoca a me pareva una cosa vera. Scrivere non mi veniva più. Nel romanzo avevo smesso di sperare. Avevo ripubblicato i miei libri principali, grazie alla gentilezza di Laurana Editore e di Lillo Garlisi; avevo raccolto, nel 2015, nel libro Favole del morire, un certo numero di pezzi scritti su commissione – spesso destinati a escuzioni più o meno teatrali – tra il 2000 e il 2011. Materialmente, non scrivevo praticamente più. A parte avventure più giocose che altro, come quella di Mariella Prestante: ma era appunto un gioco.
Qui devo confessare. Non ho mai sentito la vocazione dello scrittore. Ne ho visti, e ben conosciuti, di scrittori con la vocazione. Quella è una roba seria. Per me lo scrivere è piuttosto qualcosa che mi è capitato, e il pubblicare idem. Inventare e progettare libri, possibilmente altrui, mi piace molto; ma non mi sono mai sentito, avendo fatto un libro o dei libri, in dovere di farne degli altri. Autori unius libri, di un libro solo, ce n’è: e quelli tra loro che hanno provato a dilungarsi, solitamente hanno sbagliato. Non c’è niente di male a fermarsi. Non c’è nemmeno da rammaricarsene. Esagerare, tirare in lungo, è peggio.
Nel 2016 avevo scritto, su commissione dell’associazione Quadrivium – Associazione per la Musica Contemporanea, una “buffonata” rossiniana intitolata Quel fragoroso silenzio. In sintesi: Gioachino Rossini, dopo essere diventato più o meno l’artista più famoso d’Europa, dopo essere approdato a Parigi con l’opera seria Guillaume Tell, cade in depressione. Per mesi, forse anni praticamente non si alza dal letto. Non compone più. La compagna, e poi moglie, lo accudisce amorevolmente. Pian piano Rossini si riprende, ma non farà mai più musica d’opera. Scriverà degli album di piccoli pezzi pianistici (o per piano e voce, o per pochissimi strumenti), che intitolerà sardonicamente Pechés de vieillesse, Peccati di vecchiaia. Io li amo molto. La “buffonata” racconta, senza il minimo rispetto per la realtà storica, il “risorgimento” di Rossini dalla depressione, il suo ritorno allo scrivere musica – una musica completamente diversa, ma sempre musica. A dargli la sollecitazione decisiva sarà un perito grafologo, nientemeno… (Se qualcuno fosse interessato, qui c’è qualche estratto).
C’era, insomma, da una parte una serena (serena?) presa di posizione: “Ho finito”. Dall’altra c’erano scricchiolii, c’era un riflettere sul silenzio, c’era un desiderio (forse) che si muoveva, che tentava di sgomitare…
Continua.
2 febbraio 2021 alle 13:53
caro Mozzi, ho letto il suo romanzo, mi è sembrato molto bello, come sempre non ho capito tutto, ma spesso è indizio della qualità dello stesso.
Il fatto che sia il risultato del “collage” di testi scritti in anni lontani è la conferma della loro qualità,gli anni passati si sarebbero notati perchè sono uno straordinario rivelatore (Nome generico di dispositivi o sostanze per mezzo dei quali si può osservare o misurare un fenomeno o una grandezza).
Spero rileggerlo anche se comincio ad avere un’età e quello che ho sempre considerato il piacere della rilettura ora confligge con le troppe cose che vorrei leggere.
La ringrazio e saluto corddialmente
Rosario Morra
24 febbraio 2021 alle 11:37
Il romanzo non è un collage di testi preesisenti, Rosario. Ci ho lavorato vent’anni, e nel tempo ha “assorbito” alcuni testi, alcuni, preesistenti.
24 febbraio 2021 alle 18:24
gentile Giulio Mozzi,mi scuso ma penso di essere stato frainteso. Ho sbagliato ad usare il termine Collage che avevo messo comunque tra virgolette. perché in realtà intendevo lodare la coerenza che consente di “assorbire” i testi preesistenti cosa che non è possibile quando un’opera è caratterizzata da esigenze dettate dalla moda del momento che la rendono datata e la fanno invecchiare con una rapidità estrema.
La coerenza di un artista come Alberto Giacometti, ad esempio lo portava a lavorare senza posa sulla stessa scultura (e poco ci sarebbe restato se il fratello Diego non avesse provveduto a realizzare i gessi delle diverse fasi del lavoro) l’ansia che lo muoveva costituiva la grande coerenza, “la poetica” del suo lavoro. Io amo questa coerenza, la testardaggine di andare controcorrente nonostante le difficoltà. Quindi che lei abbia lavorato più di vent’anni al suo romanzo mantenendo compattezza e coerenza me lo fa apprezzare particolarmente.
Mi dispiace di essermi espresso male e spero di essere riuscito a chiarire cosa intendevo dire.
Grazie
Rosario
16 marzo 2021 alle 18:29
Grazie, Rosario.